Come nascono le teorie del complotto?
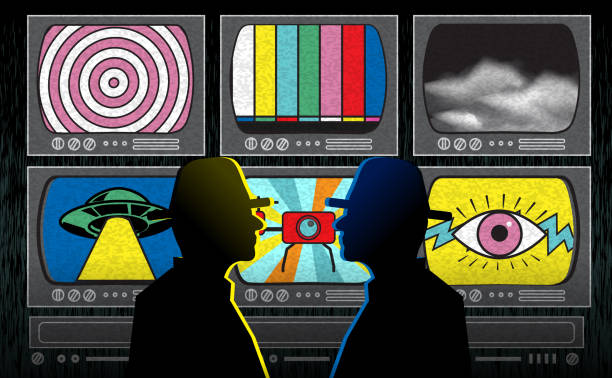
Le teorie del complotto non sono semplici bugie o malintesi. Sono narrazioni complesse, costruite spesso con la stessa cura di un romanzo d’avventura, capaci di avvolgere chi le ascolta in un mix di mistero e rivelazioni “nascoste” che promettono di spiegare ciò che appare inspiegabile. Perché ci affascinano così tanto? Forse perché ci offrono una trama chiara in un mondo caotico, o forse perché ci danno l’illusione di essere tra i pochi che “vedono oltre”.
Il fenomeno non è nuovo. Già nel medioevo circolavano storie inquietanti su “nemici occulti” che avrebbero tramato nell’ombra contro il popolo. La differenza è che oggi, grazie alla velocità dei social media e alla potenza dei motori di ricerca, una teoria del complotto può attraversare il globo in poche ore, come un virus narrativo.
INDICE DEI CONTENUTI
ToggleEcco come nascono le teorie del complotto
Ogni teoria del complotto inizia da un seme: un evento ambiguo, un’informazione incompleta o un fatto reale ma poco chiaro. Questo seme viene piantato in un terreno già pronto, fatto di:
Incertezza: quando le informazioni ufficiali tardano o sembrano contraddittorie
No ci fidiamo delle autorità: a causa di precedenti esperienze negative
Siamo alla ricerca di uno scopo: perché l’ignoto è più spaventoso del “male organizzato”
Desiderio di unicità: Vogliamo sentirci parte di una cerchia ristretta che “conosce la verità”
NOTA BENE: Quando ci troviamo davanti a una storia incompleta, il cervello tende a completarlo da sé, anche a costo di inventare pezzi mancanti che non esistono. Questa capacità diventa terreno fertile per narrazioni complottiste.
Un esempio emblematico viene da uno studio della University of Kent in cui i partecipanti, posti davanti a informazioni ambigue su un evento politico, tendevano a riempire i vuoti con ipotesi non verificate, spesso orientate verso scenari complottistici. È un meccanismo naturale. Quando la paura cresce, la fantasia prende il largo.
Esperimenti psicologici e il “bisogno di controllo”
Viviamo in un mondo in cui gli eventi globali possono travolgere la nostra vita senza nessun preavviso — crisi economiche, pandemie, guerre. Davanti a queste forze incontrollabili, l’idea che “qualcuno” sia ai comandi – anche se con intenzioni malvagie – può sembrare più rassicurante rispetto a un caos privo di regole.
Uno studio del 2015 condotto da van Prooijen e Acker evidenzia che la tendenza a credere nelle teorie del complotto aumenta quando le persone percepiscono di non poter controllare gli eventi, e viceversa diminuisce quando le persone riconoscono il fatto di avere un forte controllo nella loro vita.
Questo ci porta a un punto cruciale. Non sempre chi crede in una teoria del complotto lo fa perché è ingenuo o poco informato. A volte è un meccanismo di difesa psicologica. Come quando un bambino, spaventato da un temporale, immagina che sia “Zeus arrabbiato” a far tremare il cielo. La spiegazione è falsa, ma dona un forte senso di ordine e prevedibilità.
Dinamiche di gruppo e il contagio delle idee
Se le teorie del complotto nascono spesso da bisogni individuali come il desiderio di controllo, è nelle dinamiche di gruppo che trovano il carburante per diffondersi.
I ricercatori hanno scoperto che i gruppi funzionano come camere di risonanza. All’interno, le opinioni si rinforzano a vicenda, mentre quelle contrarie tendono a essere ignorate o respinte. Questo fenomeno, chiamato polarizzazione di gruppo, porta le persone a esprimere versioni sempre più estreme della stessa idea.
Un altro fattore potente è l’identità sociale. Credere in una certa teoria può diventare un segno distintivo, quasi come appartenere a una squadra di calcio o a una tribù. La fedeltà alla “propria verità” diventa così parte del senso di sé, rendendo molto difficile il cambiamento di opinione, anche di fronte a prove contrarie, anche se impossibili da ignorare. Non è raro che, quando un membro del gruppo viene messo in discussione, reagisca con la stessa intensità emotiva di chi difende un proprio familiare.
I bias cognitivi come carburante invisibile
I bias cognitivi rappresentano distorsioni sistematiche nei processi di pensiero e di giudizio che portano a interpretare le informazioni in modo non oggettivo.
Ecco i più rilevanti:
Bias di conferma
Tendiamo a cercare, ricordare e interpretare le informazioni in modo da confermare ciò in cui crediamo già. È il motivo per cui, se siamo convinti che un evento sia frutto di un complotto, ogni notizia ambigua diventa “una prova in più”.Proporzionalità causa-effetto
Crediamo che eventi grandi debbano dipendere da cause altrettanto grandi. Un singolo gesto sconsiderato di un leader politico difficilmente viene accettato come “errore umano”. È più probabile che sia frutto di un piano ben orchestrato.Bias dell’intenzionalità
Sopravvalutiamo il ruolo delle intenzioni rispetto al caso. Se un sistema fallisce o un evento negativo accade, ci sembra più plausibile che sia stato voluto, piuttosto che sia stato frutto di coincidenze.Illusione di correlazione
Scambiamo coincidenze per relazioni causali. Ad esempio, se dopo un certo evento accade qualcosa di negativo, potremmo pensare che il primo abbia causato il secondo, anche senza prove.Effetto Dunning-Kruger
Le persone meno esperte in un argomento tendono a sovrastimare le proprie conoscenze. Questo può portare a una pericolosa sicurezza di sé nella valutazione di presunte “prove” di un complotto.
Uno degli esperimenti più celebri sul bias di conferma è quello di Peter Wason negli anni ’60. In questo esperimento Wason chiese ai partecipanti di scoprire la regola dietro a una sequenza di numeri.
Wason scoprì che la maggior parte dei partecipanti cercava di confermare le proprie ipotesi invece di provare a confutarle. Lo stesso meccanismo si applica perfettamente al complottismo: più si cerca di “trovare prove” per ciò che già si crede, più si ignorano gli elementi che smontano la tesi.
Il ruolo dei social media come amplificatore globale
Immagina di gettare un sasso in uno stagno. Nell’era pre-digitale, le onde si propagavano lentamente tramite il passaparola, i giornali, e qualche trasmissione televisiva. Oggi, lo stesso sasso — una teoria del complotto — cade in un oceano di connessioni istantanee e le onde diventano uno tsunami in poche ore.
I social media non sono solo un canale di diffusione, ma rappresentano un ecosistema che favorisce la sopravvivenza e la crescita delle teorie del complotto. Questo avviene per tre motivi principali:
Algoritmi: Sono ottimizzati per mantenere alta l’attenzione. Inoltre, tendono a proporre contenuti simili a quelli già visualizzati. Se una persona guarda un video complottista, è probabile che ne riceva molti altri, creando una bolla informativa.
Velocità e assenza di filtro: Le informazioni non passano per un controllo editoriale. Un post virale può raggiungere milioni di persone prima che venga verificato o rimosso.
Interazione emotiva: I contenuti che suscitano paura, indignazione o sorpresa hanno più probabilità di essere condivisi. Le teorie del complotto, per loro natura, sono perfette per attivare queste emozioni.
Uno studio pubblicato nel 2018 ha analizzato circa 126 000 notizie – vere e false – su Twitter, diffuse da circa 3 milioni di utenti attraverso oltre 4,5 milioni di retweet. I risultati mostrano in modo inequivocabile che:
Le notizie false si diffondono significativamente più velocemente, più lontano, più in profondità e più ampiamente rispetto a quelle vere, in tutte le categorie di argomento.
Le notizie false hanno il 70 % in più di probabilità di essere ritwittate e raggiungono fino a sei volte più persone rispetto a quelle autentiche.
Questo effetto è particolarmente marcato nel caso delle notizie politiche.
Non sono i bot a guidare questa dinamica: l’effetto persiste anche escludendo completamente gli account automatizzati.
Ecco alcuni fatti emblematici
La storia è piena di esempi in cui le teorie del complotto hanno segnato epoche intere.
I Protocolli dei Savi di Sion
Un falso documento diffuso all’inizio del XX secolo che “provava” un piano ebraico per dominare il mondo. Nonostante fosse stato smascherato come falso, ha alimentato per decenni l’antisemitismo.L’omicidio di JFK
Le indagini ufficiali conclusero che Lee Harvey Oswald agì da solo, ma milioni di americani credettero (e credono ancora) a scenari più complessi, coinvolgendo CIA, mafia e governi stranieri.Lo sbarco sulla Luna
Nel 1969 milioni di persone seguirono in diretta l’allunaggio di Apollo 11. Pochi anni dopo, nacquero teorie secondo cui le immagini erano state girate in studio, alimentate da foto e filmati “ambigui”.11 settembre 2001
Le immagini degli attentati alle Torri Gemelle hanno dato vita a numerose narrazioni alternative che parlano di demolizioni controllate o complotti interni.
Questi casi mostrano che, una volta radicata, una teoria del complotto può sopravvivere anche quando le prove contrarie sono schiaccianti.



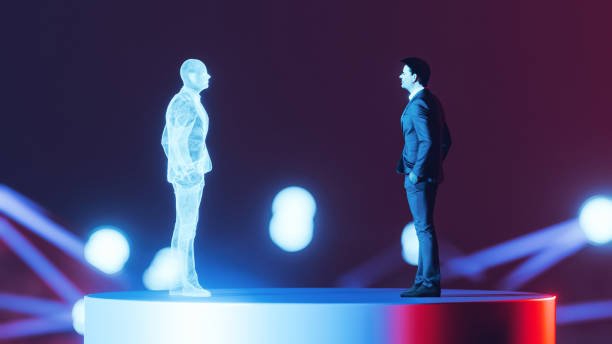










Post Comment
You must be logged in to post a comment.