Confessioni di potere: quando l’economia diventa arma

Lontano dalle telecamere e dal dibattito pubblico, sarebbero state prese decisioni in grado di influenzare il futuro di interi paesi. Non attraverso interventi militari o colpi di stato, ma tramite accordi economici, prestiti internazionali e programmi di sviluppo presentati come opportunità di crescita, ma che secondo John Perkins – ex consulente economico e autore del controverso libro Confessioni di un sicario dell’economia – avrebbero celato meccanismi di controllo e dipendenza a lungo termine.
Le sue rivelazioni hanno scosso la percezione del potere economico globale. Secondo Perkins, le multinazionali e le agenzie governative per cui ha lavorato avrebbero costruito un sistema raffinato al fine di trasformare la diplomazia economica in uno strumento di dominio. Il tutto condito da cifre astronomiche, piani di sviluppo e una narrazione di “progresso” che, a detta sua, celava una realtà ben più oscura.
INDICE DEI CONTENUTI
ToggleLe origini di un “sicario dell’economia”
Perkins racconta di essere stato addestrato per un compito ben preciso: convincere leader politici di paesi strategici a contrarre enormi prestiti internazionali. Ufficialmente, quei fondi sarebbero serviti a finanziare infrastrutture, progetti energetici, strade, porti e centrali elettriche, ma in che in realtà sarebbero serviti per tutt’altro scopo.
I prestiti, spesso calcolati su previsioni economiche gonfiate, diventavano insostenibili. Il debito cresceva, le economie nazionali si piegavano e, quando i governi non potevano più pagare, il conto arrivava sotto forma di “favori”:
Concessioni sulle risorse naturali
Appoggio politico nelle votazioni delle nazioni unite
Permessi per basi militari strategiche
Il meccanismo aveva un’efficienza chirurgica. Non servivano le guerre, ma bastava un team di “consulenti” ben preparati e il gioco era fatto. Perkins, definisce questa rete un sistema globale di controllo, una ragnatela economica in cui ogni filo è un prestito e ogni nodo una clausola nascosta.
La rete invisibile del potere economico
Se le sue parole fossero confermate, ci troveremmo davanti a un paradigma inquietante. Perkins descrive un modello a più livelli:
Il livello corporativo: multinazionali che ottengono contratti miliardari per costruire opere nei paesi debitori, trasferendo profitti fuori dai confini.
Il livello politico: governi “alleati” che favoriscono determinate aziende e orientano le decisioni internazionali.
Il livello finanziario: banche e istituzioni come il FMI e la Banca Mondiale, che diventano il cuore pulsante della strategia.
Perkins insinua che non si tratti di casi isolati, ma di un modello replicato in più paesi, dall’america latina, al medio oriente, fino ad arrivare al sud-est asiatico. Le conseguenze sarebbero devastanti: intere economie in ginocchio, governi costretti a svendere le proprie risorse, nonché popolazioni intrappolate in cicli infiniti di povertà e dipendenza.
Chi controlla il debito controlla il futuro. Questa frase, apparentemente cinica, riecheggia come un monito nelle testimonianze di Perkins. E qui nasce la vera domanda: quante delle crisi economiche che vediamo oggi sarebbero il risultato di questa strategia silenziosa?
Le tecniche di persuasione secondo Perkins
Se crediamo al racconto di Perkins, non si trattava mai di minacce dirette. La vera arte era la seduzione, non l’imposizione. I “sicari dell’economia” avrebbero operato come diplomatici eleganti, venditori di sogni con valigette piene di grafici e proiezioni scintillanti. Le armi erano altre:
Proiezioni di crescita esagerate che mostravano un futuro radioso e moderno
Pacchetti di aiuti e consulenze “gratuite” che sembravano un regalo ma in realtà erano una trappola
Legami personali costruiti con cene, regali e favori, capaci di creare un rapporto di fiducia difficile da rompere
Influenza culturale attraverso programmi di scambio e borse di studio che portavano le future élite locali a formarsi nelle università americane, assorbendo un certo modello di pensiero
La mossa finale, sostiene Perkins, arrivava quando il leader del paese si trovava già intrappolato. A quel punto, ogni resistenza era inutile. O si rispettavano i patti o entrava in gioco il secondo livello del meccanismo: la pressione politica, i ricatti velati e, in casi estremi, l’intervento di quello che lui chiama “gli sciacalli” — uomini senza volto pronti a provocare “incidenti” o rovesciare governi scomodi.
Casi emblematici e zone d’ombra
Perkins cita alcuni esempi, come l’Ecuador, il Panama, l’Indonesia o l’Arabia Saudita. Ogni storia ha il proprio copione che inizierebbe dalla riscossione di un grande prestito internazionale, e finirebbe sempre allo stesso modo: un’economia che non riesce a reggere il peso del debito.
Prendiamo l’Ecuador. Perkins racconta di come miliardi di dollari di prestiti internazionali abbiano creato un debito talmente grande che il paese fu costretto a “pagare” cedendo porzioni di foresta amazzonica alle compagnie petrolifere straniere.
O l’Indonesia, dove grandi opere finanziate da fondi esteri, a suo dire, avrebbero arricchito solo una piccola élite e lasciato milioni di persone in povertà.
Secondo lui, lo schema si ripeteva quasi ovunque, con variazioni minime. E qui si apre un’altra domanda inquietante: quante delle politiche economiche che oggi consideriamo frutto di “libero mercato” sono in realtà il risultato di accordi forzati in stanze dove il popolo non è mai stato invitato?
Il ruolo delle istituzioni internazionali
Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, nella visione di Perkins, sarebbero stati più di semplici organismi di supporto economico. Avrebbero agito come ingranaggi centrali della macchina.
Perkins sostiene che il sistema era fatto in modo tale che i loro strumenti — prestiti, piani di ristrutturazione del debito, consulenze economiche — finissero sempre per favorire i grandi interessi occidentali.
Ufficialmente queste istituzioni nascono per stabilizzare le economie mondiali e favorire lo sviluppo. Ma se i piani di salvataggio e ristrutturazione portano alla svendita delle risorse dei paesi e all’imposizione di politiche economiche di cui beneficiano soprattutto le aziende estere, a chi serve davvero il “salvataggio”?
L’ombra dell’intelligence dietro l’economia
Secondo Perkins, quando le armi della persuasione economica non bastavano, entravano in scena figure molto meno visibili. Nel libro lui li li chiama “gli sciacalli”.
Si tratterebbero di agenti legati a servizi segreti e strutture paramilitari pronte a “correggere” situazioni che stavano sfuggendo al controllo.
Il meccanismo, così come lo descrive, era tanto silenzioso quanto spietato. Leader che rifiutavano di piegarsi alle condizioni imposte potevano trovarsi di fronte a incidenti improvvisi, colpi di stato misteriosi o rivolte ben organizzate. Perkins fa nomi e date, evocando episodi che ancora oggi suscitano dubbi.
Ecco alcuni nomi:
1. Omar Torrijos (Panama) – 1981
Perkins cita il presidente panamense Omar Torrijos come un leader che rifiutò gli accordi proposti da quelli che lui definisce “sicari dell’economia”. Torrijos morì nel 1981 in un incidente aereo sospetto. Perkins lascia intendere che dietro l’incidente ci fossero forze in grado di intervenire contro chi si oppone.
2. Jaime Roldós Aguilera (Ecuador) – 1981
Altro presidente del sud america, anch’egli morto in un incidente aereo nel 1981 dopo essersi opposto ai piani di indebitamento e spoliazione delle risorse nazionali. Perkins suggerisce una narrazione simile a quella accaduta a Torrijos
In questa narrativa, l’economia diventava solo il primo atto di un copione più ampio, in cui l’intelligence giocava il ruolo del “garante” degli interessi strategici. Il messaggio implicito era chiaro: collaborare portava benefici, opporsi aveva un prezzo altissimo.
L’impatto sugli equilibri geopolitici
Se il racconto fosse reale, la portata storica sarebbe immensa. Lungi dall’essere semplici episodi isolati, questi interventi avrebbero ridisegnato confini politici, orientato alleanze militari e determinato chi poteva accedere a determinate risorse.
Pensiamo al petrolio in medio oriente. Perkins sostiene che alcuni accordi multimiliardari, apparentemente bilaterali e legittimi, fossero in realtà il frutto di lunghe manovre economiche, pressioni diplomatiche e un uso calibrato di leve militari.
Il risultato? Un controllo quasi totale delle rotte energetiche da parte delle potenze occidentali. Un equilibrio fragile che, come una torre di carte, poteva crollare al minimo cambiamento.
La rete si evolve
Perkins avverte che il “modello” non è rimasto fermo agli anni ’70 o ’80. Col tempo si sarebbe perfezionato, diventando ancora più difficile da individuare. L’ingresso di nuovi attori sulla scena globale — Cina, India, fondi sovrani arabi — ha complicato il gioco, ma non lo ha sostituito.
Oggi, le leve di controllo non passerebbero solo per i prestiti infrastrutturali. Si parlerebbe di
Accordi commerciali multilaterali con clausole asimmetriche
Controllo delle tecnologie chiave e dei brevetti
Influenza nelle organizzazioni internazionali
Penetrazione nei mercati finanziari locali con investimenti mirati
Il tutto condito da un nuovo strumento potentissimo: il controllo dei dati e delle piattaforme digitali. Perché, come dice Perkins, chi controlla l’informazione controlla la percezione, e chi controlla la percezione controlla il consenso.
Le conseguenze sociali di un debito “programmato”
Il peso reale di queste manovre non si misurerebbe soltanto nei bilanci degli stati ma anche nella vita quotidiana di milioni di persone. Un debito eccessivo non è solo una cifra su un foglio di calcolo. È una catena invisibile che condiziona ogni decisione politica, sociale ed economica.
Nei paesi coinvolti, i governi si trovano costretti a tagliare la spesa pubblica per rispettare i piani di rientro. Ciò significa:
Ospedali senza fondi e personale ridotto
Scuole in condizioni precarie e programmi educativi interrotti
Infrastrutture essenziali lasciate a metà o mai completate
Aumento della disoccupazione e precarietà diffusa
In parallelo, grandi opere costose — spesso inutili per le reali necessità locali — vengono portate a termine, ma il loro beneficio ricade soprattutto sulle aziende straniere che le hanno costruite. Il cittadino comune resta a guardare, mentre il “miracolo economico” promesso si dissolve come nebbia al sole.
Generazioni intrappolate
Perkins descrive una spirale in cui il debito non viene mai veramente ripagato. I prestiti per saldare vecchi prestiti creano un effetto valanga. Intere generazioni nascono già con un futuro ipotecato.
Le conseguenze psicologiche sono profonde: si diffonde una cultura della rassegnazione, la convinzione che “così vanno le cose” e che il paese non potrà mai emanciparsi. In alcuni casi, l’emigrazione di massa diventa l’unica via di fuga, svuotando i paesi delle loro forze più giovani e competenti.
E mentre le ricchezze naturali — petrolio, minerali, foreste — vengono esportate a basso costo, la popolazione resta con le mani vuote. Perkins non parla solo di economia, ma di un vero e proprio meccanismo di depredazione sistemica, un’arte raffinata di spogliare una nazione mantenendola formalmente “sovrana”.
Le confessioni dietro le quinte
Uno degli aspetti più inquietanti del racconto di Perkins riguarda le confidenze che, a suo dire, avrebbe ricevuto da colleghi e funzionari. Incontri in hotel di lusso, conversazioni sussurrate nei corridoi delle conferenze internazionali, nonché frasi lasciate cadere a metà come se bastasse un cenno per capirsi.
Alcuni avrebbero ammesso di sapere esattamente quale fosse il vero scopo dei progetti che stavano “vendendo” ai governi stranieri. Altri si sarebbero giustificati dicendo che “così funziona il mondo” e che “meglio noi che altri”. Un cinismo che Perkins descrive come una corazza necessaria per non crollare sotto il peso morale di certe decisioni.
Ci sarebbero stati anche leader politici stranieri consapevoli del gioco, ma pronti a parteciparvi in cambio di benefici personali o per garantire la propria sopravvivenza politica. In un sistema simile, chi si oppone diventa un bersaglio, e chi si adegua diventa complice.
Le critiche al racconto di Perkins
Ogni volta che una testimonianza tocca corde così profonde e mette in discussione interi assetti di potere, le reazioni non tardano ad arrivare. Il libro di John Perkins è stato accolto da alcuni come una rivelazione, mentre da altri come un’opera di pura fantasia o esagerazione.
Alcuni economisti e analisti politici hanno accusato Perkins di semplificare eccessivamente scenari complessi, mescolando eventi reali con interpretazioni personali difficili da verificare.
Ci sono poi ex colleghi e funzionari che negano categoricamente l’esistenza di un meccanismo sistematico di “sicari dell’economia” così come lo descrive. Secondo loro, le grandi opere finanziate nei paesi in via di sviluppo sarebbero state parte di strategie genuine di cooperazione, anche se non sempre perfettamente eseguite.
Eppure, c’è un dato difficile da ignorare: esiste un’inquietante somiglianza tra i casi raccontati da Perkins e le dinamiche reali osservabili in diverse nazioni. Coincidenza o prova implicita? Questo resta uno dei punti più dibattuti.
Altre osservazioni
Alcuni studiosi suggeriscono che ciò che Perkins descrive potrebbe essere una versione estremizzata di pratiche realmente esistenti, ma più caotiche e meno coordinate di quanto lui sostenga. Non un piano centralizzato controllato da pochi, bensì un insieme di interessi convergenti che finiscono per produrre effetti simili.
In quest’ottica, le istituzioni internazionali e le multinazionali non sarebbero sempre “burattinai”, ma attori che agiscono in base alla propria logica di profitto e influenza, generando conseguenze che, intenzionali o meno, rafforzano determinati equilibri di potere.
Altri ancora leggono il racconto di Perkins come un’avvertenza più che una cronaca. Una sorta di monito sul fatto che, in un mondo interconnesso, il denaro e il debito possono diventare strumenti di pressione più potenti delle armi.
Personalmente, ritengo più plausibile quest’ultima ipotesi.
Implicazioni per il futuro
Se anche solo una parte di ciò che Perkins racconta fosse reale, le implicazioni per il futuro sarebbero inquietanti. La globalizzazione, già segnata da squilibri profondi, potrebbe diventare una gabbia ancora più stretta se questi meccanismi si evolvessero tramite l’avvento delle tecnologie moderne.
Immaginiamo uno scenario in cui non solo il debito, ma anche il controllo dei dati, delle infrastrutture digitali e delle intelligenze artificiali diventi una leva di potere.
In un contesto simile, il “sicario dell’economia” del XXI secolo non avrebbe più bisogno di grafici e previsioni economiche gonfiate. Gli basterebbero algoritmi e sistemi di sorveglianza economica per condizionare governi e mercati in tempo reale.
Perkins stesso avverte che la consapevolezza è il primo passo per resistere. Capire i meccanismi, individuarli e denunciarli potrebbe non fermare il sistema, ma almeno renderlo meno invisibile.
Conclusioni
Che lo si consideri un testimone scomodo o un narratore capace di intrecciare fatti e suggestioni, John Perkins ha aperto una finestra su un mondo di cui pochi parlano.
La sua storia ci costringe a fare domande scomode: chi controlla davvero il destino economico delle nazioni? Quanto di ciò che chiamiamo sviluppo è frutto di scelte libere, e quanto invece il risultato di un debito sapientemente orchestrato?

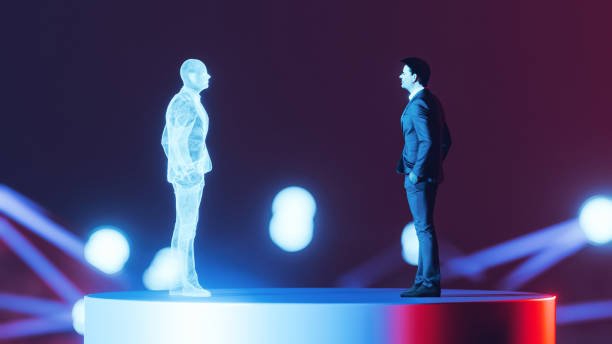











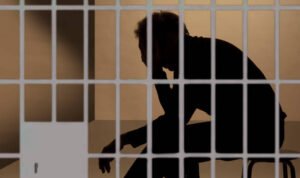
Post Comment
You must be logged in to post a comment.