Il nostro DNA racconta una storia che nessun libro di storia ha mai detto
Hai mai pensato da dove veniamo? Non in senso poetico, ma proprio in termini biologici: chi erano i nostri antenati? Fino a ieri, la risposta più condivisa era piuttosto lineare: l’Homo sapiens è nato in Africa circa 200-300.000 anni fa, figlio di un singolo lignaggio ancestrale, e da lì ha colonizzato il mondo.
Ma oggi, grazie a uno studio dell’Università di Cambridge pubblicato su Nature Genetics, sappiamo che la verità è decisamente più affascinante. E anche un po’ più complicata.
Due popolazioni, una sola specie
Analizzando il DNA di popolazioni moderne provenienti da tutto il mondo, i ricercatori hanno scoperto che non discendiamo da un solo gruppo di antichi umani, ma da almeno due popolazioni ancestrali separate. Queste si sarebbero divise circa 1,5 milioni di anni fa, per poi riunirsi 300.000 anni fa, mescolando per sempre i loro patrimoni genetici.
Una delle due popolazioni ha contribuito all’80% del nostro genoma. L’altra, con un contributo più modesto (circa 20%), potrebbe però aver dato un’accelerata a ciò che ci rende davvero umani, come le funzioni cerebrali più complesse.
Insomma, il nostro DNA è una specie di cocktail genetico. E non è affatto un male.
Il metodo? Niente ossa, solo algoritmi
Questa scoperta è arrivata non scavando fossili, ma analizzando direttamente il DNA umano moderno. I ricercatori hanno utilizzato i dati del 1000 Genomes Project, una banca genetica globale, e li hanno elaborati con un algoritmo sviluppato appositamente. Tale algoritmo prende il nome di cobraa ed è stato utilizzato in questo studio al fine di ricostruire come si siano divise e riunite le popolazioni passate.
Questo metodo permette di “vedere” nel passato anche in assenza di resti fisici. È come usare una macchina del tempo genetica!
Il collo di bottiglia evolutivo: che cosa significa?
Immagina una grande popolazione di esseri umani antichi che, per qualche motivo — magari un disastro naturale, una malattia, o la scarsità di risorse — si riduce a un gruppo molto piccolo di individui. Questo evento si chiama “collo di bottiglia” evolutivo, dato che è come se passassero tutti attraverso il collo stretto di una bottiglia: da tanti, si diventa pochi.
E quando una popolazione si riduce così tanto, gran parte della diversità genetica viene persa. Solo i geni dei pochi superstiti continuano a essere tramandati.
È proprio quello che è successo a una delle due popolazioni ancestrali da cui discendiamo. Questa popolazione ha vissuto un collo di bottiglia, ma poi è sopravvissuta e si è ripresa, crescendo lentamente fino a diventare la linea principale dell’Homo sapiens moderno.
E l’altra popolazione? Un piccolo contributo… ma forse decisivo
Nel frattempo, l’altra popolazione, quella che ha dato solo il 20% circa del nostro DNA, non è sparita, ma ha lasciato un’impronta più piccola. Però… interessante!
Alcuni dei geni provenienti da questo gruppo sembrano collegati a funzioni importanti, come lo sviluppo del cervello e la capacità di elaborare informazioni. In altre parole, anche se il loro contributo genetico è stato minore in quantità, potrebbe aver influito molto sulla qualità di ciò che siamo diventati. Potremo definirli la ciliegina sulla torta!
Selezione naturale e DNA “compatibile”
Un altro punto interessante è che molti dei geni di questo “gruppo minore” si trovano lontano dalle zone chiave del nostro DNA — quelle che contengono istruzioni importanti per costruire il corpo e farlo funzionare.
Questo fa pensare che alcune delle varianti genetiche che ci hanno trasmesso non si adattavano bene al “sistema genetico” della popolazione dominante, e perciò la selezione naturale le ha eliminate nel tempo. Questo processo si chiama selezione purificante: è come una specie di filtro che tiene solo le varianti più utili o più compatibili, e scarta le altre.
Però attenzione: “poco” non vuol dire “inutile”!
Anche se quella seconda popolazione ha lasciato meno geni, le varianti che sono sopravvissute potrebbero essere state fondamentali. Pensa a una squadra di calcio: magari un giocatore tocca pochi palloni, ma è quello che segna il gol della vittoria. Ecco, quei geni potrebbero aver fatto proprio questo: un piccolo contributo, ma decisivo per lo sviluppo di caratteristiche chiave dell’essere umano.
E ora?
I ricercatori vogliono spingere ancora più in là questo approccio. Il modello cobraa è già stato applicato anche ad altre specie — pipistrelli, gorilla, delfini — e promette di rivoluzionare lo studio dell’evoluzione, andando oltre la vecchia idea di “linee di discendenza pure”.
Siamo sempre stati abituati a pensare all’evoluzione come una linea retta. Ma forse assomiglia più a una rete intricata, dove gruppi si separano, si incrociano, si fondono, e a volte si perdono nel tempo.
E i nostri misteriosi antenati?
Al momento, i candidati più probabili per rappresentare queste due popolazioni ancestrali sono rappresentate dall’ Homo erectus e dall’ Homo heidelbergensis, presenti in Africa e altrove proprio nel suddetto periodo. Ma non ci sono ancora certezze, e serviranno altre prove — magari fossili, magari genetiche — per avere conferme.
Una cosa è chiara però: non siamo il prodotto di una singola linea retta, ma di una storia intrecciata, ricca e sorprendente.
Perché questa scoperta ci riguarda tutti?
A parte l’aspetto scientifico, questa ricerca ci ricorda una cosa importante: la diversità è nella nostra natura. Non siamo il risultato di un unico gruppo, ma di un’unione. E questo, in un mondo che spesso fa fatica ad accettare le differenze, è un bel messaggio da portare con sé.
Ci racconta anche quanto possa essere potente la genetica moderna: ci permette di ricostruire eventi avvenuti centinaia di migliaia di anni fa, semplicemente leggendo il nostro DNA. Incredibile, no?


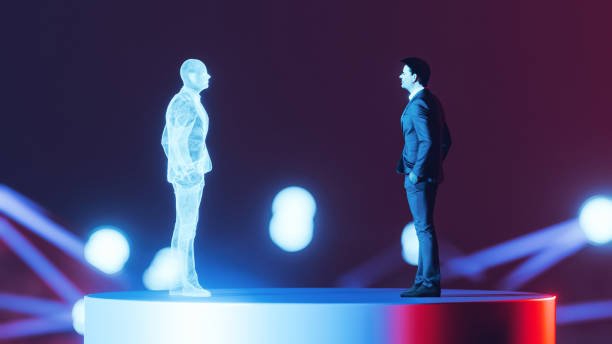












Post Comment
You must be logged in to post a comment.