L’erbicida più utilizzato al mondo è ora collegato alla leucemia e ai tumori
Il glifosato è oggi l’erbicida più usato al mondo. Viene impiegato da agricoltori, giardinieri e squadre di manutenzione per eliminare le erbacce che soffocano le colture.
Il suo meccanismo sembra semplice: blocca un enzima essenziale per la crescita delle piante, portandole lentamente alla morte. Poiché questo enzima non esiste negli animali e negli esseri umani, il glifosato è stato a lungo considerato sicuro, tuttavia ne siamo davvero sicuri?
Negli ultimi decenni, proprio mentre l’uso del glifosato si è moltiplicato, sono emerse nuove domande: questa sostanza può influire sulla salute del suolo e sulla biodiversità? Può avere effetti a lungo termine sulla salute umana?
Lo studio italiano che fa discutere
Per fare chiarezza, il centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni presso l’istituto Ramazzini, in Italia, ha condotto un vasto studio sugli effetti del glifosato. Da oltre cinquant’anni questo centro analizza il modo in cui le sostanze chimiche influiscono sul rischio di tumore.
Lo studio ha seguito ratti Sprague-Dawley per due anni, iniziando l’esposizione addirittura in gravidanza. Una scelta importante, perché il periodo prenatale è una “finestra critica” in cui l’organismo è particolarmente vulnerabile.
Gli animali hanno ricevuto in questo modo tre differenti livelli di esposizione (0,5, 5 e 50 milligrammi per chilo al giorno), dosi considerate accettabili dalle autorità di regolamentazione. Non solo glifosato puro, ma anche due prodotti commerciali noti con il nome di Roundup BioFlow in Europa e RangerPro negli Stati Uniti.
I ricercatori non si sono limitati a guardare “in generale” se i ratti stessero bene o male, ma hanno fatto un’analisi molto dettagliata. Hanno osservato decine di organi (fegato, reni, tiroide, pelle, ecc.) seguendo protocolli scientifici standard e facendo anche revisioni indipendenti per ridurre al minimo errori o interpretazioni soggettive.
E cosa hanno scoperto? Dal punto di vista “generale” – quindi peso corporeo, quanto mangiavano e bevevano, e quanto vivevano complessivamente – non c’erano grandi differenze rispetto ai ratti non esposti al glifosato. In altre parole: i ratti non apparivano più deboli, né più magri, né con una vita più corta in senso globale.
Ma quando si è andati a guardare nel dettaglio gli organi e i tessuti, è emerso un quadro diverso: un aumento di tumori, sia benigni che maligni, in vari punti del corpo. Questo significa che il glifosato non provocava segni evidenti di malessere “generico”, ma agiva in modo più subdolo, favorendo la comparsa di tumori nascosti, che non si sarebbero notati senza analisi approfondite.
ECCO COSA DICONO I RISULTATI DELLO STUDIO: La durata media della vita degli animali esposti al glifosato non appariva molto diversa da quella del gruppo di controllo, cioè i ratti che non avevano ricevuto la sostanza.
Tuttavia, guardando più da vicino, i ricercatori hanno osservato un dato importante: una parte degli animali sviluppava tumori molto precoci, come la leucemia, che ne accorciavano drasticamente la sopravvivenza.
In pratica, mentre la maggioranza dei ratti trattati viveva a lungo quanto i controlli, una minoranza mostrava un esordio rapido e aggressivo della malattia, con conseguenze letali già nelle prime settimane.
Tumori e leucemia: i segnali più preoccupanti
I dati parlano chiaro: sono stati osservati aumenti di tumori, sia benigni che maligni, in diversi organi – pelle, fegato, tiroide, sistema nervoso, ovaie, reni, ghiandole surrenali, vescica, pancreas endocrino e perfino nella ghiandola mammaria maschile.
Ma il dato più inquietante riguarda la leucemia. Nei gruppi esposti si è registrata una correlazione dose-dipendente: più glifosato, più casi. Nei controlli, invece, nessun episodio.
Ancora più sorprendente è stato l’esordio precoce: circa il 40% dei decessi per leucemia avveniva già entro il primo anno di vita degli animali, un evento rarissimo in questo ceppo di ratti nei test di lunga durata.
Non solo: i risultati variavano a seconda della formulazione usata, suggerendo che i coformulanti (cioè gli altri ingredienti presenti nei prodotti commerciali) potrebbero peggiorare ulteriormente la tossicità complessiva, rispetto al glifosato puro.
Dati sugli animali e dati sugli esseri umani
Questi risultati si aggiungono a un quadro già complesso. Già nel 2015 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) aveva classificato il glifosato come “probabilmente cancerogeno per l’uomo”, sottolineando prove sufficienti negli animali da esperimento e segnali di genotossicità e stress ossidativo.
Negli esseri umani, però, i dati sono meno chiari. Ad esempio, l’ “Agricultural Health Study” negli Stati Uniti ha evidenziato un possibile aumento di leucemia mieloide acuta tra gli applicatori di pesticidi maggiormente esposti, anche se con margini statistici incerti.
Per la maggior parte degli altri tumori, le associazioni sono risultate nulle.
E allora? Come spesso accade nella ricerca scientifica, non esiste una risposta unica e definitiva, tuttavia questo il dibattito resta aperto.
Cosa dicono i regolatori?
Le autorità di regolamentazione, infatti, non parlano sempre la stessa lingua.
In Europa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nel 2023 ha sostenuto il rinnovo del glifosato, pur riconoscendo “lacune” nei dati, soprattutto per gli effetti sugli organismi acquatici e sulla mancanza di trasparenza sugli ingredienti delle formulazioni.
Negli Stati Uniti, invece, l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) ha dovuto ritirare nel 2022 la sua decisione provvisoria, dopo che una corte federale ha chiesto di rivedere la valutazione sugli effetti sulla salute umana.
In sintesi: le stesse evidenze scientifiche vengono interpretate in modo diverso, a seconda dell’approccio delle agenzie.
Perché questo studio è così importante?
L’aspetto cruciale dello studio italiano è l’esposizione prenatale. Esporsi già nel grembo materno, e poi per tutta la vita, può produrre effetti diversi rispetto a un’esposizione iniziata solo in età adulta. E questo è un dato fondamentale per la salute pubblica.
Un’altra ricerca californiana, ad esempio, ha trovato che bambini con più alti biomarcatori di glifosato presentavano maggiori probabilità di enzimi epatici elevati e sindrome metabolica nell’adolescenza. Segnali che meritano attenzione.
Quali sono le domande che restano aperte?
Il nodo centrale oggi non è solo capire se il glifosato sia “pericoloso in assoluto”, ma piuttosto:
Cosa accade quando ci si espone a basse dosi per tutta la vita?
Qual è l’effetto delle formulazioni commerciali rispetto al principio attivo puro?
Quanto i dati sugli animali possono essere tradotti alla popolazione umana?
Sono domande che incidono direttamente sulla valutazione dei limiti di sicurezza e sull’uso di questo erbicida nei campi e nei nostri ambienti quotidiani.
Conclusione
La vicenda del glifosato mostra quanto sia complesso il rapporto tra progresso agricolo, economia e salute pubblica. Da un lato, questo prodotto ha reso più semplice e redditizia la gestione delle colture, tuttavia le evidenze scientifiche mostrano problematiche difficili da ignorare.
Come cittadini abbiamo i diritto di chiedere più trasparenza, più studi indipendenti e, perché no, anche alternative più sostenibili.



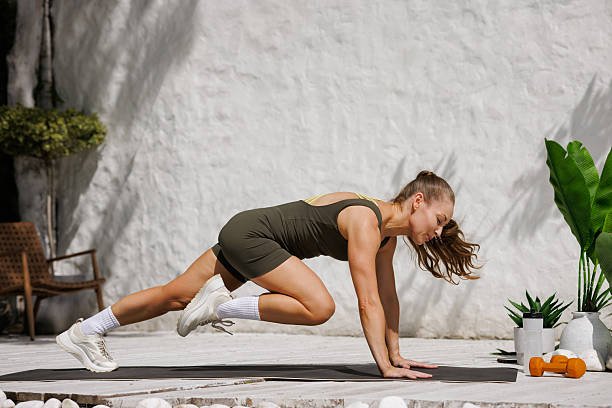











Post Comment
You must be logged in to post a comment.